
Dentro l’esposoma: salute, città e futuro
Tempo di lettura
0 min
Gloria Bertoli ci guida in un viaggio tra scienza, ambiente e medicina personalizzata
Cosa c’entra la biodiversità urbana con la nostra salute quotidiana? E perché la medicina del futuro dovrà tenere conto dell’ambiente in cui viviamo, della qualità del nostro cibo, dell’aria che respiriamo e perfino delle condizioni del nostro quartiere? Per rispondere a queste domande abbiamo intervistato Gloria Bertoli, direttrice dell’Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi del CNR e co-leader dello Spoke 6 di NBFC. L’intervista è un vero e proprio viaggio dentro il concetto di “esposoma”, un termine tecnico fondamentale per comprendere come ogni stimolo che riceviamo influenzi la nostra salute. Il tema è tanto scientifico quanto umano, e ha profonde ricadute non solo in campo clinico, ma anche sociale, ambientale ed economico.
Protagonisti dell’intervista
Gloria Rita
Bertoli
- Biologa cellulare e molecolare
- Istituto di Bioimmagini e Sistemi Biologici Complessi del CNR
- gloriarita.bertoli@cnr.it Copia indirizzo email
NBFC e biodiversità urbana: un approccio multidisciplinare
Dottoressa Bertoli, da dove nasce il vostro progetto e qual è il suo obiettivo principale?
“Il nostro lavoro si inserisce nel grande progetto NBFC. In particolare, coordino lo Spoke 6 con la collega Hellas Cena. Il progetto coinvolge oltre 300 ricercatori e ricercatrici con competenze molto diverse – dalla matematica alla medicina, passando per la fisica, la bioinformatica e la biotecnologia. E proprio questa multidisciplinarietà è uno dei punti di forza di NBFC. L’ambito di studio di Spoke 6 è l’area urbana, scelta non a caso: il 63% degli italiani vive in città, e spesso l’ambiente urbano è sinonimo di inquinamento, stress e stili di vita poco salutari. L’obiettivo è ambizioso: valorizzare la biodiversità urbana e comprenderne l’impatto sulla salute. Lo possiamo fare solo capendo come l’esposoma ha un impatto sul nostro benessere”.
Cos’è l’esposoma e perché è così importante
Entriamo nel cuore del suo lavoro: che cos’è l’esposoma?
”L’esposoma è l’insieme degli stimoli, esterni e interni, a cui siamo esposti nel corso della nostra vita. Parliamo di fattori ambientali, alimentari, psicologici, sociali… tutti in grado di influenzare la nostra biologia a livello molecolare”.
Può farci un esempio concreto?
”Certo. Pensiamo all’inquinamento, all’illuminazione solare, alla dieta, all’attività sportiva, ovviamente ad alcol e fumo, al livello di stress – ma anche al reddito o all’istruzione. Tutto ciò che incontriamo ogni giorno – l’aria che respiriamo, i cibi che mangiamo, il quartiere in cui viviamo – contribuisce al nostro stato di salute o di malattia. Sembra incredibile, ma miliardi di cellule rispondono agli stimoli dell’esposoma modulando l’espressione di specifiche molecole che possono influenzare il nostro stato di benessere o di salute. A Milano, per esempio, chi vive in periferia ha spesso accesso a cibo più scadente a causa del suo ridotto reddito. E questo comporta una carenza di macro e micronutrienti, con conseguenze sulla salute. La medicina non può più ignorare l’impatto di questi fattori”.
“Molte terapie si basano su statistiche: se funzionano sull’80% dei pazienti, vanno bene. Ma noi vogliamo arrivare a curare anche quel 20% che oggi resta ai margini”.
Gloria Bertoli
L’esposoma interno e il ruolo del microbiota
Esiste poi un esposoma interno, è corretto?
”Esatto. Parliamo di tutte quelle molecole che hanno un ruolo nell’infiammazione cronica, e nello stress ossidativo, e che possono influenzare il metabolismo; tra queste, molte originano da un elemento chiave presente nel nostro corpo, il microbiota intestinale. Il microbiota è l’insieme dei microrganismi che vivono nel nostro intestino e che sono persino più numerosi delle nostre cellule”.
Che ruolo ha il microbiota nella nostra salute?
”Fondamentale. Oltre a trasformare il cibo in molecole utili, regola processi immunitari e infiammatori. Se si altera l’equilibrio tra le varie popolazioni microbiche o se c’è un cambiamento nel numero di membri di una popolazione rispetto ad un altra, il rischio è di compromettere tutto il sistema, favorendo malattie croniche o degenerative”.
Verso la medicina personalizzata
Un altro ambito su cui lavora è la trascrittomica. Di cosa si tratta?
”La trascrittomica studia tutto ciò che la cellula legge nel DNA e trasforma in molecole funzionali. Quindi noi analizziamo queste molecole alla ricerca di marcatori. Nello specifico, stiamo cercando di individuare le molecole capaci di predire, in qualche modo, lo stato di salute dell’individuo. Un individuo sano avrà certi marcatori; nell’individuo malato gli stessi saranno profondamente alterati (aumentati all’eccesso o ridotti al minimo) nei livelli di espressione. Questo sbilanciamento altera le funzioni di una cellula o di un tessuto. Molte delle malattie non ereditarie (oncologiche, metaboliche o neurogenerative) presentano una base caratterizzante comune, ovvero aumentati livelli di stress ossidativo e infiammazione. Individuare i fattori chiave molecolari ed epigenetici che caratterizzano questi due aspetti significa trovare marcatori su cui possiamo lavorare dall’esterno. E mediante lo studio di queste molecole associate a stress ossidativo ed infiammazione possiamo anche vedere come l’esposoma di cui abbiamo parlato prima impatta sul nostro stato di salute”.
In che direzione state andando?
”Verso una medicina personalizzata. Immaginiamo una donna a cui la mammografia ha rilevato una massa sospetta. In futuro, prima di arrivare alla biopsia, uno screening molecolare potrebbe indicarci di che tipo di tumore si tratta. Questo permetterebbe all’oncologo di scegliere subito il trattamento più mirato. Non avremmo più una cura “uguale per tutti”, ma costruita su misura. Oggi molte terapie si basano su statistiche: se funzionano sull’80% dei pazienti, vanno bene. Ma noi vogliamo arrivare a curare anche quel 20% che oggi resta ai margini”.
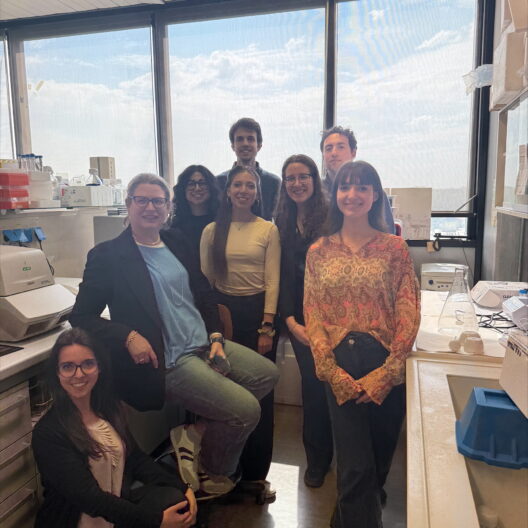
Biodiversità e salute: un legame inscindibile
Che legame c’è tra tutto questo e la biodiversità urbana?
”Una malattia non è solo un errore in una reazione chimica. È anche il frutto dell’ambiente in cui viviamo. Una città priva di verde, caotica, rumorosa e inquinata espone il cittadino a uno stress ossidativo continuo, causando a livello molecolare un aumento del cortisolo, che ha ad esempio effetto sul nostro metabolismo, sulla nostra ricerca di cibo ed incrementa l’obesità e le malattie metaboliche. È per questo che promuoviamo un modello urbano diverso, più verde, più connesso, più a misura d’uomo”.
Quindi l’urbanistica diventa una questione di salute pubblica?
”Assolutamente sì. Una buona pianificazione urbana può ridurre il rischio di malattie. Quartieri accessibili a piedi, reti di trasporto efficienti, spazi verdi e accesso a cibo sano sono strumenti di prevenzione determinanti. Allo stesso modo anche il luogo di lavoro ci deve dare stimoli positivi: il verde intorno e dentro gli uffici, una corretta illuminazione naturale, un ridotto rumore di fondo, sono tutti elementi che a livello inconscio lavorano sul nostro benessere psicofisico”.
Impatti sul mondo del business
Tutto questo può interessare anche le imprese?
Eccome! Pensiamo a test rapidi e a basso costo per il monitoraggio della salute, a integratori calibrati su età e stili di vita, a cibi funzionali progettati sulla base delle esigenze individuali. Oppure alle tecnologie per mappare lo stress ambientale in città. Il futuro è già qui: serve solo la volontà di investirci.
Guardare al futuro: salute e biodiversità per le nuove generazioni
Come immagina il futuro del suo campo di ricerca?
Penso a una medicina sempre più preventiva e meno invasiva, dove si cura prima ancora che si manifesti la malattia. Dove la salute dell’individuo è letta in chiave sistemica, cioè considerando corpo, mente e ambiente. Io credo che il nostro lavoro abbia una forte valenza etica e sociale. C’è moltissimo da fare, sia per noi che per i più giovani. Non dimentichiamoci che dal 2022 lo dice anche la nostra Costituzione, all’art. 9: la Repubblica italiana “Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”.

