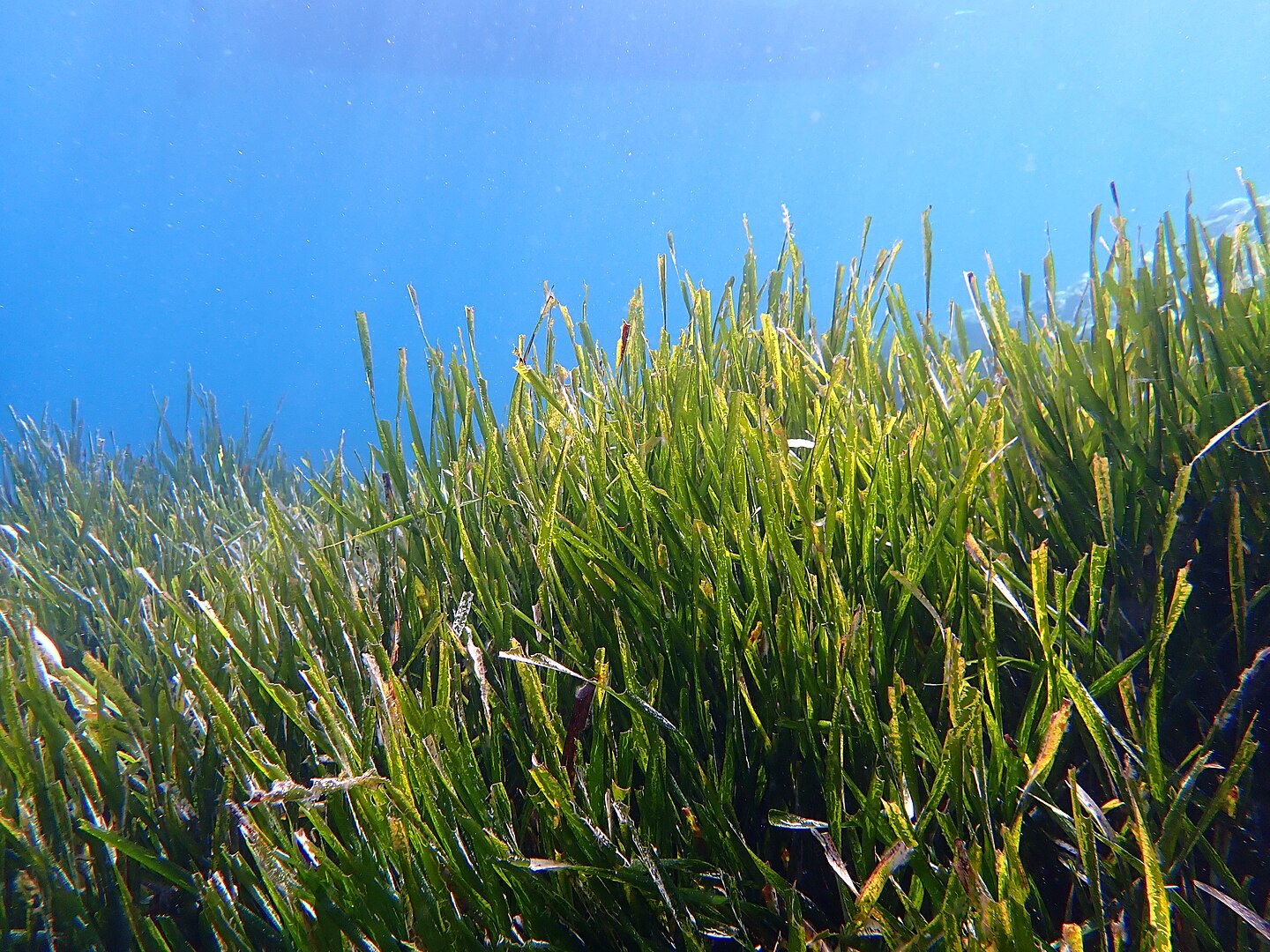
Cold case: luce su eventi di milioni di anni fa
Tempo di lettura
0 min
Scoperta grazie a un team internazionale la reale portata della Crisi di Salinità del Messiniano
Uno studio pubblicato su Science riapre un cold case dei più antichi, e grazie a un approccio multidisciplinare riscrive la storia della biodiversità mediterranea.

“Questo studio dimostra l’importanza della sinergia tra ricercatori di diverse discipline”
Angelo Camerlenghi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS
Un evento catastrofico: la Crisi di Salinità del Messiniano
Come spiega la ricerca, a cui hanno preso parte 25 istituti in tutta Europa (tra cui anche l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e l’Università di Firenze), tutto ebbe inizio con la Crisi di Salinità del Messiniano, un evento geologico sconvolgente che, tra i 6 e i 5,5 milioni di anni fa, vide la chiusura dello Stretto di Gibilterra, l’isolamento del Mar Mediterraneo dall’Oceano Atlantico, e di qui in poi una serie di avvenimenti che trasformano radicalmente il paesaggio e gli organismi che lo abitavano.
La chiusura dello stretto provocò un’intensa evaporazione delle acque del Mediterraneo; l’evaporazione a sua volta causò un drastico abbassamento del livello del mare, fino quasi al suo completo prosciugamento; l’abbassamento delle acque, per parte sua, provocò un enorme deposito di sali (tra cui gesso, anidrite e salgemma). Si formò così un “gigante di sale”, spesso in media un chilometro, che ebbe sulla biodiversità marina del Mediterraneo un impatto devastante.
L’indagine, partendo dai fossili
La nuova ricerca fa luce su quegli avvenimenti remoti, che i ricercatori hanno ricostruito partendo dalla creazione di un database con 22.932 occorrenze fossili di 4.897 specie marine provenienti da diverse località del Mediterraneo.
L’analisi di questi fossili, che risalgono a un periodo compreso tra il Tortoniano (11.63-7.25 milioni di anni fa) e lo Zancleano (5.33-3.6 milioni di anni fa), ha permesso agli scienziati di quantificare la ricchezza delle specie prima, durante e dopo la Crisi, e di comprendere la reale portata del suo impatto.
Quantificare un disastro e il tempo di recupero
Lo studio, nello specifico, ha evidenziato come il gigante di sale e le fluttuazioni della temperatura abbiano dato origine a un ambiente estremamente ostile per la maggior parte degli organismi marini: solo l’11% delle specie endemiche del Mediterraneo riuscì a sopravvivere al nuovo ambiente ipersalino.
Le analisi mostrano inoltre che la scomparsa di tante specie portò a una profonda ristrutturazione degli ecosistemi marini, e che il recupero della biodiversità impiegò molto più tempo di quanto non si ritenesse in precedenza. Dopo la riconnessione con l’Atlantico, al Mediterraneo servirono almeno 1,7 milioni di anni per ristabilire condizioni ambientali favorevoli e vedere le proprie acque ricolonizzate poco alla volta.
La Crisi di Salinità Messiniana lasciò infine un’altra importante eredità: è da attribuire a quell’epoca, sostengono gli scienziati, il fatto che procedendo da ovest (ovvero da dove si riaprì lo Stretto di Gibilterra) a est il numero di specie marine diminuisca progressivamente.
“Questo studio”, ha concluso Angelo Camerlenghi, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS, “dimostra l’importanza della sinergia tra ricercatori di diverse discipline. Sulla base delle indagini geologiche e geofisiche è stato possibile identificare la dimensione dell’evento della crisi di salinità messiniana che ha permesso a paleontologi e paleoecologi di quantificare la resilienza delle specie biologiche a una perturbazione ambientale alla scala di tutto il Mediterraneo”.













